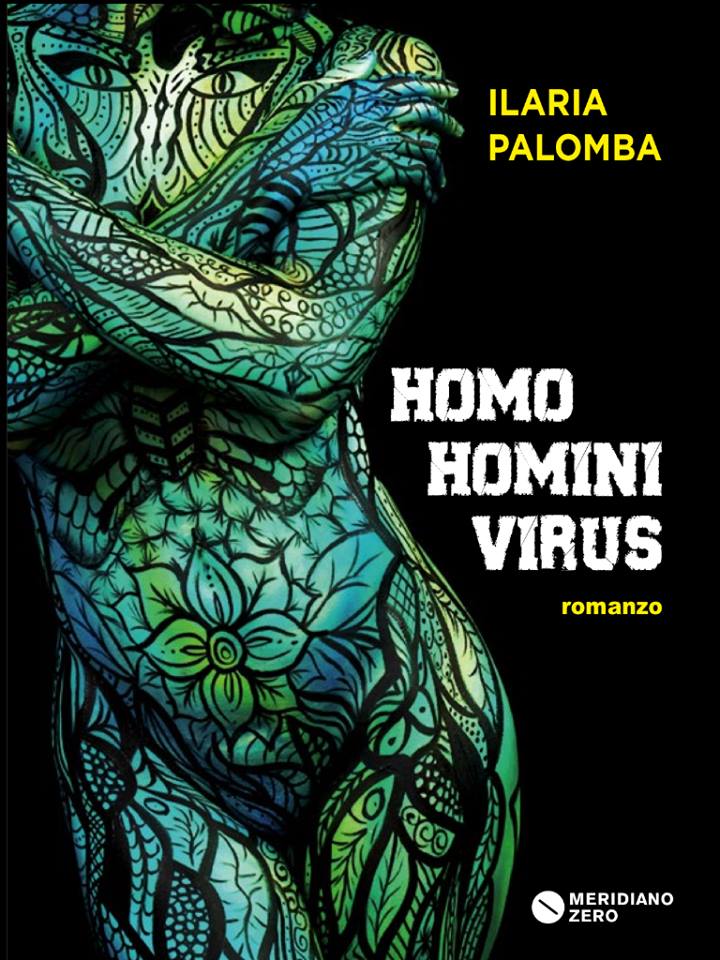Mi accostavo al mare, solo l’eterno scorrere delle acque poteva mitigare la colpa. La sentivo fluttuare con la potenza degli abissi. C’era una caletta che chiamavamo Spiaggia Grande ma non era poi così grande. Vi si accedeva per un sentiero nella pineta. Le alte fronde spazzolavano il cielo, c’era l’odore dei pini, lo stormire delle cicale. I passi risuonavano ovattati. Il fragore delle ciabatte, il fruscio della bora estiva, le vesti leggere e arancioni mosse dal vento come le fronde. Alla fine del sentiero la luce, il mare, quel mare del Salento, così chiaro e cristallino, e tutto un pullulare di esseri nella caletta sotto le rocce.
Mi piaceva strisciare le dita nella calce, nell’argilla e restarne graffiata. Lo facevo per sentirmi viva, questo era il dolore, cognizione di sé, consapevolezza. Che cos’era l’eternità? Me lo chiedevo sempre dopo i primi baci e i tradimenti, me lo chiedo ancora. Chi desiderare? Chi amare? Qual è la cosa giusta?
Avevo quindici anni ed ero contesa, per quanto non mi trovassi bella, al contrario, scrutandomi allo specchio prima di uscire non potevo fare a meno di notare certi segni che allora già chiamavo rughe, erano nere macchie e solchi sotto gli occhi e lungo la linea delle guance. Avevo quindici anni e cinquanta insieme. Forse non ero degna della promessa, forse era l’aspetto di quella lì, che mi fissava nello specchio, così sinistro, a spingermi a tradire. Sono così brutta, come posso piacere agli uomini? Uno mi aveva promesso fiabe e celestiali poesie, l’altro lacrime e tormenti. Non sapevo scegliere e mi muovevo silente tra le onde lasciando posare gli sguardi.
L’amore docile di Alessandro, che mi aiutava a scalare montagne di roccia, l’odore della calce, i baci di sottecchi nell’arco scavato dal mare e sotto a nuotare, lui che m’insegnava come trattenere l’aria senza premere le dita contro il naso, io che scivolavo giù e all’inizio bevevo e avevo rossi gli occhi di sale e inesperienza. Aveva diciassette anni Ale e io l’avevo illuso. L’avevo illuso? O m’ero illusa io stessa di una vita. Quanto dura l’eternità? Forse una settimana, al calore del sole mentre leggo Anna Karenina e non capisco proprio tutto, penso alle altre che guardo algide e dinoccolate, profumi d’arancia e cannella, piedi sinuosi, corpi scolpiti. Il palpitare delle onde e i surfisti, la ragazza mora che parla con Ale e io non capisco, vedo e non sento, ma lui guarda me. Le passa attraverso con gli occhi e guarda me. Cosa ci trova in me? Cosa ci vede? Mi chiedevo. Sono domande che non bisogna porsi e continuare forse a contrastare l’assenza con tutti i significati di cui si dispone. Erano dolci i suoi baci, sempre di soppiatto, al gusto delle cose nascoste, come rubare le arance al giardino affianco o scavalcare il muretto della casa abbandonata.
Mia madre diceva che Alessandro fosse buono, gli guardava gli occhi nocciola e li sentiva veri. Nelle profondità dei suoi occhi c’era il rispetto per la mia età e l’attesa di un domani insieme mentre oggi poteva insegnarmi a nuotare e scalare.
C’erano anche altri ma non li vedevo. Li incontravo la sera sulla stessa lingua di sabbia illuminata dalla luce del fuoco, dove cuocevamo la carne, le ragazze perfette facevano il bagno a mezzanotte e io restavo in disparte.
Una notte seguivo la luce crepuscolare del fuoco fin dalla pineta. Alessandro era rimasto a casa, qualcuno dei suoi stava poco bene. Oppure era una scusa. A mia madre dissi che vi sarei andata con lui e con lui sarei tornata. E invece, sola, in pineta, nella notte varcavo soglie proibite e mi allungavo verso l’altro versante della costa. Non di falò era la luce ma di danze notturne e fari e locali proprio sul mare. Una schiera di ragazzi seduti sopra una collina a fumare spinelli. Io non sapevo che farmene e non mi piaceva la musica alta ed elettrica e non mi piacevano gli sguardi che avevano, come non vedessero nulla.
Non ero la sola a esser sola. Portava jeans strappati alle ginocchia e capelli lunghi sul viso, scuri. Occhi così chiari da fare luce nella notte. Forse era il mare, la spregiudicata luminescenza dell’acqua prima di divenire abisso. Aveva efelidi come chicchi di pepe e non parlava con nessuno. Beveva vino in bottiglia da solo. Si mise a sedere al mio fianco.
Ehi.
Non mi parlare, tra un po’ me ne vado.
Dove?
A casa.
E dov’è casa?
Lì, dietro quegli alberi, indicai la pineta.
Sorrise. Aveva, lui sì, rughe attorno agli occhi come tagli. Due fossette oltre le labbra. I denti lievemente storti e quando rideva pareva cattivo.
Beata te. Io mi sa invece che a casa non ci torno.
E dove vai?
Non lo so. Lontano. Vuoi venire con me?
Cosa significa lontano?
Vado fin dove posso, con quello.
Indicò un tre ruote Piaggio azzurro come i suoi occhi. I capelli neri, lunghi, gli coprirono il volto, s’intrecciarono alle labbra. Mi passò la bottiglia di vino. Bevvi. Aveva un sapore di grumi, ruggine, sangue. E non pensai.
Perché non vuoi tornare a casa?
Mi guardò. E aveva negli occhi un’ombra. Era rabbia. Ma anche paura.
Tu fai troppe domande.
Sulla maglietta nera c’era una scritta che diceva: non cercarmi. Fui tentata di domandargli anche di quella. E mi trattenni. Continuai a bere.
Hai sete.
Nient’altro.
Conto fino a tre, poi mi alzo e vado via. Se vuoi vieni con me, altrimenti addio bambina senza nome.
Bambina?
Uno.
Fissava il mare. Le lampare rosse e blu dei pescatori, le lenze. Il faro sopra la collina.
Due.
Prese dalla tasca un pacchetto di sigarette e un accendino. Accese.
Tre.
Si alzò e si avviò al suo particolarissimo mezzo di locomozione.
Avevo il battito cardiaco accelerato. Mi mettevo in continuazione i capelli dietro le orecchie per poi ributtarli sul viso. Respiravo a fatica. E comunque, nonostante la musica, sentivo il fiato venire fuori con un rumore troppo forte. Il fragore di un motore che s’accende. Lasciai la bottiglia ormai vuota. Ruzzolò giù per la collina. Mi misi a correre.
Aspettami.
Entrai. Dovevamo stringerci per stare in un posto solo. Lui aveva l’odore del tabacco. Il Piaggio andava lento e ballonzolava a destra e a manca. Faceva sempre quel rumore e sempre più potente man mano che ci allontanavamo dalla gazzarra. Le dita sul volante erano come scheggiate. Il puzzo delle sigarette che fumava e i pacchetti di cenere riversi sul fondo del mezzo di locomozione particolare.
Perché sei salita?
Come ti chiami?
Tu?
Giulia.
Michele.
Mi diede la mano togliendola dal volante. Sulla strada non c’era nessuno. Ai bordi la campagna di ulivi e vigneti nel buio pareva una foresta nera.
Sai almeno dove stai andando? E se poi finisce la benzina? Hai dei soldi? Quanto tempo vuoi stare lontano?
Smise di nuovo di guardare la strada e guardò me, con la cenere che ruzzolava sui miei vestiti chiari, estivi, di mare. E sulle cosce, bianche, intatte, di bimba.
Perché mi hai seguito?
Voglio andare lontano anch’io.
Lontano da cosa?
Da me.
Cos’hai nella borsa?
Un libro.
Rise. E di nuovo il volto si fece crudele.
Di che parla?
Di una donna sposata che s’innamora di un altro, tradisce e si rovina.
Il Piaggio s’inceppò in una fossa, il motore si spense. Michele sacramentò. Scendemmo. La strada era dismessa, colma di buche, per metà asfaltata e per metà terreno. Non c’era l’ombra di un’anima a destra e a sinistra. Michele diede un calcio a una ruota. Piansi e feci in modo non se ne accorgesse. Continuavo ripetermi: perché sei venuta qui, cosa cercavi, e quando farà l’alba e non sarai a casa, e se non riuscite a tornare, morirete di sete e di fame, fa freddo qui giù, e se ci sono i mostri nel bosco, e se Michele è cattivo e ti uccide.
Vento. La pelle raggricciata faceva vortici viola. Michele diede un altro paio di calci. Mi vide tremare. Mi cinse le spalle. Aveva braccia ancora calde, mani ruvide.
Vieni, arriviamo alla fine della strada.
Voglio tornare a casa.
Non puoi.
Che significa?
Sorrise. Ed era un sorriso pieno di lame. Mi venne vicino. Piangevo. Piangevo. Carezzò le guance.
Da cosa stai scappando?
E tu?
Da qualcosa che non ho fatto.
Continuò ad asciugarmi le lacrime. E aveva nelle dita la delicatezza di un bambino. Le sentivo, le sue dita, colme di premura, quasi volesse liberarmi dal peso del timore. Il corpo smetteva di trattenerla, la paura. Man mano si dileguava. E nasceva in me come una sete, il desiderio potente di lasciarmi rapire.
Mi prese per i capelli e mi baciò. Aveva morbide le labbra, soffici e sottili. Non arrivammo alla fine della strada. I baci furiosi. Avevano un sapore diverso. Eterno, questi sì, disperato. Salimmo sul rimorchio del Piaggio. Era sporco di cenere e terra. Era freddo. Rabbrividivo poggiandovi la schiena.
Solo i suoi occhi parevano rifulgere al buio e io mi ci univo. La lingua nella mia. Sapore di vino, tabacco, e sangue. Le mani sui seni. Cercai di fermarle. Non mi sembrava giusto. E lui non si fermò. Slacciò il nodo del vestitino estivo, arancione. Non portavo il reggiseno, restai nuda, mi divincolai ma non più di tanto. Fece correre la lingua sul collo, sui seni e sul ventre e poi giù, levando gli slip, dolcemente leccava mentre mi torcevo nel piacere. E non vedevo e non sentivo. Mi accorsi, ed era troppo tardi. Me ne accorsi solo per il dolore. Era un dolore dolcissimo. Mi prendeva la nuca i capelli mentre entrava e guardandomi negli occhi diceva: Giulia, Giulia, dimmi che sei mia. E lo dicevo.
Vidi i suoi occhi farsi bianchi. Un calore tumido sporcava le cosce, la vulva. Saliva nel ventre. Lui mise una mano tra le mie cosce e la tirò fuori rossa. Rise e diventò cattivo ma durò solo un istante.
Che cosa ho fatto?, piansi.
L’amore.
E mi attaccò il sangue alle guance.
Continuai a piangere e lui mi strinse forte a sé, finché non smisi. Crollai esausta sul corpo suo.
La notte non pareva estiva, un vento gelido muoveva le cose di una sottile impermanenza. Fui svegliata da bordate di freddo. Odore di brina. Il fondo metallico del montacarichi mi ghiacciava la schiena. Michele non era con me. C’era mai stato? Odore di brina.
Saltando scesi in strada. Dissi il suo nome. Il vento rispose ululando. I piedi sull’asfalto umido parevano mossi da mani di nebbia. La campagna mi chiamava, le fronde erano volti, con occhi luminosi come quelli di Michele.
Dimmi, dove sei. Cosa può il tuo sguardo che la notte trattiene. Dimmi, chi sei. Dove ti ho già visto. Quanto lontano ci siamo spinti. Quanto profonda è la terra. Cosa nasconde il cuore del bosco. Camminavo e i sandali venivano via. Il terriccio freddo si arrotolava alle caviglie come pelle di serpe. Una luna altissima iridava di un pallore niveo il fondo della suolo. Le foglie d’ulivo come occhi. I rami tentacoli. L’immensità si cela negli incubi del bosco. Si aggrovigliavano i rami nell’oscurità di un cielo nero trafitto dal bianco pallore della luna, i rami muovevano le dita per afferrarmi. Chiamavo il suo nome. Il vento rispondeva ululando. Non era un ululato, era il grido di tutte le bestie, dal serpente al lupo, e s’infittiva muovendomi verso un altrove. Finivo nella terra e pensavo alle serpi, alle serpi, attorno alle caviglie. Era solo terra e aria ma pareva viva, come vivi erano i tentacoli di rami, a ogni passo più prossimi alla carne. Fantasie di apnea e strangolamento. Occhi chiari come lucciole nel buio. E poi la bruma.
Nel ventre oscuro del bosco di ulivi, una nube di bruma ottundeva una sagoma. Viva? Morta? Spettro? La pelle raggricciata. Il fiato che ingoia sé stesso. Questo terrore cavo nella bocca dello stomaco.
Michele, dove sei? Ti prego, torna!
La nuvola di bruma lasciava il tempo alla sagoma di divenire corpo. Guardavo nel fondo della nebbia. Un uomo sopra un masso. Occhi dell’azzurro del mare. Capelli neri sul viso. Efelidi come chicchi di pepe. Una sciabolata di rughe attorno agli occhi e alle labbra. Indossava un abito scuro, da cerimonia.
Vieni, Giulia, vieni con me.
Mi tese la mano. Salii. Il masso si tramutò in altare. Un parroco dal volto coperto in una maschera bianca chiedeva: vuoi sposarlo? Michele mi guardava con occhi crudeli e io stessa mi guardavo, avevo indosso un lungo abito bianco, di seta e pizzo, e alle dita pure, uno smalto bianco, un anello sottile, d’oro. E gli occhi azzurri di Michele, come spade, s’imprimevano in me.
Devi solo dire sì, lo voglio.
Lo dissi.
E mentre c’incamminavamo lungo la navata centrale di una chiesa romanica, la gente intorno ci seguiva con il riso nei pugni, il paesaggio ancora mutò.
Ero sola in una casa dalle pareti fredde. Il miasma di umido era l’odore dei panini insaccati nella stagnola e lasciati in frigo per giorni. Michele non c’era. Mi aggrappavo alle pareti. Michele non c’era. Mi aggrappavo ai muri, al calcestruzzo. E i muri venivano via.
Dov’eri la notte, quando non potevo vederti. Dove si nascondeva il sentire. Dov’erano le promesse e le parole piene svuotate da gesti mai compiuti.
Riversa sul pavimento pativo il freddo di tutti gli inverni e nello stomaco avevo il vuoto di una vita. Di fronte a me un cassettone in ebano. Una cornice. La fotografia di una bambina bionda, vestita di rosa. Di cinque o sei anni.
Dov’è lei. Che fine ha fatto il futuro. Chi ha rubato la gioia al castello del tempo. E dove sono le ore trascorse sulla roccia, sul mare, a pregare affinché si salvasse almeno una parte di me.
Il telefono squillava e non era Michele. Dov’era.
Chi sei?
Stai bene?
Cosa vuoi?
Sono Alessandro.
Cosa vuoi?
Hai bisogno di qualcosa?
Di morire.
Giulia…
Cosa faceva Ale ora che avevo la vita frantumata dall’assenza. Veniva a portarmi via dal buio. Le veneziane chiuse. I passi senza suono. La casa un cimitero. Perché c’era ancora. Quando arrivava scostava le tende. Apriva gli scuri. Entrava la luce. La luce del sole mi disintegrava come fa con gli spettri.
Hai mangiato?
Silenzio.
Vuoi uscire?
Silenzio.
Alessandro mi portava al mare. La roccia della Spiaggia Grande era crollata. Restavamo sui frantumi di pietra a guardare la tempesta di onde, nere, bianche, azzurre. E in quell’azzurro rivedevo Michele. La spuma fondersi con le spaccature di un cielo invernale, invaso da lampi. C’era il presagio di un’apocalisse e lui mi guardava come una cosa perduta in adolescenza. Una cosa perduta e spaccata, i cui vetri non possono ricomporsi.
Dov’è Michele?
Se n’è andato, devi dimenticarlo.
E dov’è?
Giulia, ti prego.
Il gusto della tempesta aveva invaso anche il mare. Nel fondo delle onde vedevo la vita divelta. Le scelte sbagliate. L’omicidio del senso. La bambina che giocava con l’acqua. La bambina che si arrampicava nella roccia. Non le avevo insegnato a nuotare e scalare, come Alessandro aveva fatto con me. La bambina saliva sulle rocce. E si lanciava in mare. Non aveva paura dell’acqua. Non aveva paura del volo. Non aveva paura di nulla. E l’acqua se la prese. Per sempre. Il corpo non fu ritrovato.
Al mattino Michele l’andava a cercare. Nella roccia. Nel mare. Sul fondo dei suoi occhi. Tornava al tramonto, sconfitto. Beveva. Qualunque cosa, beveva. Non mangiava. E non mi toccava più. Finché non smise. Di tornare.
Io lo vedevo nelle tende, nelle fessure delle veneziane, negli spazi di luce trafitti dal buio. Io lo vedevo la notte leggendo il soffitto. Lo sentivo respirarmi accanto al mattino, senza smettere mai. Quando veniva Alessandro l’odiavo. L’odiavo come si odiano i risvegli mentre il sogno mi teneva ancorata a un mondo ancora integro. Ogni risveglio è una spaccatura nella coscienza. Manda in frantumi l’illusione che hai fatto di te.
Il cielo nero si spaccò in un’ombra di luce. Un nitore chiarissimo di azzurri e violetti sorse insieme al fulgido baluginare del sole, sgusciato dalle onde come la testa di un uomo di fuoco.
Mia madre aveva chiamato Alessandro, le aveva detto non fossi con lui. Aveva chiamato i genitori di qualche altro amico. Aveva saputo del falò e che mi fossi allontanata nella notte. Mia madre aveva avvisato la polizia. La polizia conosceva Michele. Il padre di Michele. La famiglia di Michele.
Ci trovarono all’alba nel bosco. Io gridavo il suo nome. Avevo quindici anni e cinquanta insieme. C’era il fragore di un’ambulanza. Il suono di una sirena. Vidi Michele in manette guardarmi per l’ultima volta.
Ed è quella buona, disse una guardia. Quella buona che non esci più.
Erano spade, i suoi occhi, e s’incidevano in me con l’inesorabilità della colpa. Qualcuno disse stupro. Nessuno comprese quando mi gettai ai suoi piedi singhiozzando: perdono.
Rividi mia madre, Alessandro. Mi stavano accanto come fossi davvero una vittima. Ma io sapevo, e avevo nel cuore quegli occhi azzurri, il colore degli abissi prima del fondo. E andavo sul mare da sola. Ricordando il futuro. Quanto tempo servirà per cancellare la memoria della colpa.
© i. p.